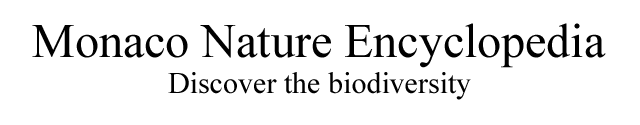Questa pianta ha 2.000 anni. Straordinario reportage su un ” fossile vivente ” del deserto della Namibia. Stava inventando il fiore. Ha solo 2 foglie, che crescono senza sosta sfilacciandosi al contatto del suolo rovente del deserto. Gli insetti pronubi. Incredibili astuzie per sopravvivere.








Testo © Giuseppe Mazza
“Slow, slow, please”, ripeto da circa 3 ore all’autista che guida gagliardamente la mia jeep, fra i sassi della Namibia, come una Rolls su un’autostrada tirata a lucido.
Non è più una richiesta, ma qualcosa a metà fra una supplica e il bisogno di scaricare la coscienza, ogni sobbalzo, dai possibili danni alle macchine fotografiche.
Molleggio come posso gli obiettivi, tenendoli sospesi fra le braccia, e controllo, con la coda dell’occhio, la borsa delle pellicole esposte e di “pronto impiego”. Non so più dove metterla: il sole ha ormai scaldato tutti i sedili, e il fondo dell’auto, teoricamente all’ombra, è quasi rovente per l’attrito.
Il posto meno caldo è al centro, 20 cm circa sotto il tetto, e lì, faticosamente, aggancio la borsa, con la sadica soddisfazione di vederla sbattere sulla testa del mio “driver” ogni volta che esagera o prende male la strada.
Il poveretto è la prima volta che guida da queste parti: rimpiange da due giorni gli “avventurosi” turisti che s’accontentano delle abbeverate d’Etosha, e teme di perdere il contatto con l’auto della nostra guida, John Lavranos, botanico esploratore, collaboratore del famoso Missouri Botanical Garden di Saint Louis.
“Due jeep con quattro ruote motrici e un buon autista”, mi aveva chiesto subito per telex, come gli avevo prospettato un reportage sulla Welwitschia.
Anche se il deserto della Namibia è appena il 5% del Sahara, ogni anno miete le sue vittime. Le ruote slittano e s’insabbiano, i motori fondono, ed entrarvi con un sol mezzo è pura follia. La nostra pista non è nemmeno segnata sulle carte, e se non fosse per la nuvola bianca di polvere dell’auto di John, spesso non sapremmo dove voltare.
Finalmente si ferma per mostrarmi un’impressionante distesa di variopinti licheni, segno che lì si formano delle condense e che la vita, in qualche modo, è possibile. Da sotto un masso, spunta una piccola pianta, simile a un cactus. Cresce approfittando di un paio d’ore d’ombra e della rugiada che scivola lungo la roccia.
In genere, mi spiega, si definisce deserto un luogo dove l’evaporazione potenziale è il doppio delle precipitazioni medie. Qui cadono al massimo 20 mm all’anno, la sabbia supera i 70 °C, l’aria i 40 °C, e il rapporto sarebbe di 1 a 200 con nessuna possibilità di vita.
Ma al mattino presto e alla sera, dal mare giungono spesso le fitte nebbie che si formano, lungo la costa, per effetto della corrente fredda del Benguela, e si è calcolato che 100 giorni di nebbia equivalgono ad almeno 50 mm di pioggia.
Per sopravvivere nei deserti le piante usano 3 strategie: immagazzinano l’acqua nei grandi vacuoli delle cellule, come questa succulenta, riducono la dispersione di liquidi con foglie caduche, minuscole o trasformate in spine, o evitano la stagione secca con una crescita lampo, da seme a seme, concentrata nel breve periodo in cui piove.
La Welwitschia mirabilis, una perenne con due enormi foglie non caduche, esce completamente da questi schemi, perché non è una pianta del deserto, ma l’incredibile adattamento a un clima arido di un albero della foresta.
Lo guardo perplesso.
Dalle rocce, continua, si ricava con precisione l’età del Namib Desert, 60 milioni di anni al massimo, e la Welwitschia appartiene a un gruppo di piante molto più antiche, le gimnosperme, che hanno avuto la loro massima diffusione 135-205 milioni di anni fa, quando qui cresceva lussureggiante una foresta pluviale.
Sembra incredibile pensarlo, fra nuvole di sabbia e rocce sgretolate dal sole, ma in sostanza stiamo cercando gli ultimi alberi d’una foresta preistorica.
Improvvisamente ne troviamo uno, poi un altro, un altro ancora, e finalmente un’esemplare enorme, con oltre 4 m di diametro.
Avrà quasi 2000 anni, commenta John, mentre penso emozionato a Friedrich Martin Joseph Welwitsch, il medico e naturalista austriaco che scoprì la Welwitschia, vicino a Cabo Negro in Angola, il 3 settembre del 1859.
Cadde in ginocchio, sbigottito, sul terreno ardente, credendo di sognare. Charles Darvin la definì poi “l’ornitorinco del regno vegetale”, e capisco in un attimo come la mancanza d’attrattive estetiche sia, per un botanico, irrilevante e l’appellativo “mirabilis” più che giustificato.
Cresce in stazioni discontinue, continua John, là dove penetrano le nebbie, fra 25 e 120 km dalla costa, lungo una striscia di circa 1000 km, che va dal Kuiseb River, in Namibia, a Moçamedes, in Angola.
Ci chiniamo sul groviglio di foglie, bruciacchiate all’apice, che si intrecciano fra loro come i serpenti sul capo della mitica Medusa.
In realtà sono solo due.
Crescono senza sosta, 10-20 cm all’anno, come capelli da un tronco acefalo. Potrebbero teoricamente raggiungere il metro e mezzo di larghezza e una lunghezza indefinita, ma nel loro continuo movimento le punte toccano il suolo, bruciano, si sfilacciano e col tempo le foglie si spezzano in tante strisce, lungo le nervature parallele.
È l’unico caso, mi spiega, di foglie perenni con accrescimento secondario. Un tessuto meristematico produce di continuo nuove cellule e nella sua lunga vita questa pianta avrà già fabbricato almeno 1000 m² di foglie, un’immaginaria pista sportiva verde lunga 400 m e larga 3.
Le tocco : sono dure, coriacee, mancano del rivestimento ceroso tipico di molte piante del deserto ed offrono al sole una superficie enorme, come se la pianta abbondasse d’acqua.
Avranno pochissimi stomi, commento, pensando alle perdite legate alla fotosintesi nel deserto.
Al contrario, ne contano oltre 250 per mm², su entrambi i lati, più della maggior parte delle piante. Un ricordo, forse, della vita “alla grande” trascorsa, milioni d’anni fa, nelle foreste pluviali.
D’accordo, ma oggi?
Più le “bocche” sono numerose, mi spiega, meglio assorbono le rugiade del mattino. Poi, durante il giorno, quando l’aria diventa calda e secca, spesso si chiudono e la Welwitschia adotta un particolare metabolismo, il CAM (Crassulacean Acid Metabolism), scoperto per la prima volta in un gruppo di piante grasse, le Crassulaceae.
Apre gli stomi solo di notte o all’alba, quando fa fresco e l’anidride carbonica può entrare senza che il vento e il caldo si portino via troppa acqua, fissa provvisoriamente il CO2 in acidi organici e lo trasforma più tardi, col sole, in zuccheri ed amidi.
Un metabolismo sorprendentemente evoluto in una specie, per molti versi preistorica.
Da un punto di vista sistematico, continua John, la Welwitschia mirabilis è una gimnosperma, una pianta cioè a “seme nudo”, parente delle cicadacee (piante simili a piccole palme coltivate anche da noi in riviera), del ginkgo e delle ben note conifere.
Alla loro comparsa, le felci avevano già inventato il sistema vascolare, delle cellule per trasportare l’acqua dal suolo alle foglie, ma la riproduzione era ancora affidata all’umidità della foresta e alle spore.
Le gimnosperme furono le prime a inventare il seme, una sorta di “piantina in scatola” con riserve nutritive e molte più possibilità di successo di un organismo unicellulare come una spora. Forse, agli inizi, i semi nascevano sotto le foglie, ma in seguito queste si trasformarono in scaglie, che le gimnosperme sistemarono abilmente, una sull’altra, in strutture a forma di pigna.
Poi vennero le piante da fiore, le angiosperme, che per proteggere e diffondere meglio i semi, inventarono l’ovario e il frutto. La Welwitschia, per la sistematica ancora una gimnosperma, segna il punto di passaggio fra questi due gruppi di piante.
Mi mostra i microscopici fiori maschili (come nelle cicadacee e in molte specie primitive i sessi sono separati: le piante, dette dioiche, presentano cioè solo organi maschili o femminili) : spuntano da scaglie di piccole “pigne”, portati da corti peduncoli.
Hanno già un rudimentale perianzio, mi spiega, costituito da 2 brattee interne (futuri petali) e 2 esterne (futuri sepali) che proteggono 6 antere ed una specie di pistillo, che conduce a un ovario sterile. Un vero fiore, quindi, anche se solo abbozzato.
È impossibile dire se fu il primo, certo le altre piante che ci provarono, oggi sono estinte e la Welwitschia è l’unico testimone vivente dello storico passaggio.
Alla base dei peduncoli, là dove sbucano dalle scaglie, notiamo delle strane goccioline, di cui nessuno ha mai parlato nei libri. Forse acqua o nettare per attirare gli insetti.
Anche se per certi autori l’impollinazione è affidata al vento, continua John, in pratica se ne occupa un insetto, il Probergrothius sexpunctatus, che vive quasi in simbiosi con la Welwitschia.
Passa gran parte della sua vita succhiando i coni femminili, e favorendone l’infezione da parte di funghi microscopici, contribuisce a far sì che sui 10.000-20.000 semi teorici per pianta, se ne salvino solo 20-200 all’anno.
Ma come? lo interrompo incuriosito, dov’è il vantaggio?
Benché alati, mi spiega, i semi della Welwitschia in genere non vanno lontano: urtano nel groviglio di foglie e cadono vicino al tronco.
Ma nei deserti, dove le risorse sono scarse, le giovani piante non possono permettersi d’entrare in competizione con la madre: devono crescere, cioè, almeno a una certa distanza. Per esser certi di non restare a metà sviluppo senz’acqua, i semi sono coperti da potenti inibitori germinativi (per rimuoverli occorrono almeno 25 mm di pioggia, continua o concentrata in 2-3 giorni) e il Probergrothius sexpunctatus, provocandone la morte e la caduta, fa sì che questi si sciolgano quasi tutti alla base della pianta. In breve il terreno intorno è intriso di sostanze antigerminative, e la nascita di concorrenti impossibile.
Di fatto le Welwitschia più vicine distano diversi metri, e sembra che anche le gigantesche radici, a forma di carota, immettano nel suolo sostanze tossiche. Profonde quanto la larghezza della pianta, hanno un’importante funzione di riserva, e assorbono, con spugnose ramificazioni laterali fra i 25 e i 75 cm di profondità, l’acqua che filtra nel sottosuolo.
L’impollinazione, continua John, avviene fra novembre e marzo. Poi i coni femminili si gonfiano, le scaglie si sollevano, e i semi vengono dispersi dal vento. Ricchi in proteine e carboidrati, estremamente igroscopici, possono aspettare anche 3 anni, e quando le condizioni sono favorevoli germinano in 10-20 giorni.
Sviluppano rapidamente una radice e due cotiledoni, capaci di fotosintesi, superati in grandezza, verso il 4° mese, dalle foglie definitive.
Improvvisamente da una pianta sbuca un topolino: ci guarda stupito per un attimo e rientra nel suo piccolo universo verde. Si nutre dei semi della Welwitschia ed è in pratica l’unica preda della vipera del deserto.
Un insetto, un topolino, un serpente e un albero, uniti da millenni in un delicato equilibrio, in quella che gli indigeni chiamano “la terra che non invecchia”, il più antico deserto o forse, perché no, la più antica “foresta” del mondo.
NATURA OGGI + SCIENZA E VITA + CA M’INTERESSE – 1987